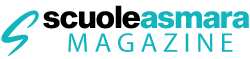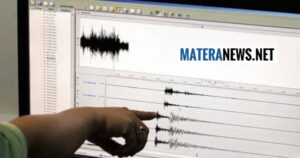“Correzione” è senza dubbio uno dei romanzi più significativi di Thomas Bernhard, ripubblicato ora da Adelphi con traduzione di Giovanna Agabio. Questo capolavoro, apparso per la prima volta nel 1975, ci immerge in un labirinto di ossessioni e riflessioni che delineano il profilo di un autore geniale e controverso. La narrazione si snoda tra angosce esistenziali e introspezioni, svelando non solo la vita di Roithamer, ma anche una critica più ampia alla cultura austriaca e alla condizione umana.
Il personaggio di Roithamer e il suo mondo interiore
Roithamer, protagonista indiscusso del romanzo, rappresenta la complessità di un genio che si confronta con il proprio destino. Amico d’infanzia e professore di matematica a Cambridge, la voce narrante si trova a dover affrontare le opere postume di questo personaggio enigmatico, il quale ha dedicato gli ultimi anni della sua vita a un ambizioso progetto: costruire un cono utopico nel cuore di un bosco. Quest’opera, concepita per essere un dono alla sorella, scava nel profondo delle relazioni familiari e dei legami affettivi, complessi e a volte tragici. La drammaticità di Roithamer si intensifica ulteriormente con la morte della sorella, evento che lo riduce a un’esistenza priva di significato e lo conduce verso un tragico epilogo.
Il romanzo esplora quindi la vita di un uomo immerso in un mondo di libri e formule scritti sulle pareti di una soffitta, un simbolo di isolamento e frustrazione intellettuale. Bernhard, con il suo stile inconfondibile, riesce a trasmettere la sensazione di avvolgimento della mente e del corpo in un’esperienza che è tanto puramente personale quanto universale. L’ossessione per la perfezione emerge con forza attraverso la figura di Roithamer, un uomo consapevole della sua grandezza ma al tempo stesso schiacciato dalla sua incapacità di raggiungere l’illuminazione completa.
La riflessione sulla cultura austriaca e l’istruzione
Una delle tematiche più rilevanti che attraversano “Correzione” è il rapporto conflittuale di Bernhard con la sua patria, l’Austria. L’autore si interroga sui suoi legami con una cultura che, sebbene gli abbia dato origine, lo ha anche profondamente deluso. Descrive l’Austria come un’entità ambivalente, caratterizzata da una storia che trasmette solamente “bastonate” e rifiuti. Questa conflittualità risuona attraverso i suoi sentimenti nei confronti della scuola, vista come un’istituzione che ha continuamente umiliato i suoi studenti. La voce narrante esprime una profonda disillusione, raccontando di come ogni esperienza scolastica sia stata segnata da depressione e frustrazione.
La critica all’istruzione emerge come una riflessione necessaria sul valore della cultura e del sapere. Bernhard sembra porre in discussione la rigidità del sistema educativo, la quale, invece di alimentare la creatività e il pensiero libero, tende a conformare, soffocando gli spiriti più audaci. Il romanzo diventa così un manifesto di libertà intellettuale, mettendo in luce l’importanza di un’educazione che vada oltre le norme e le convenzioni sociali.
La musica come strumento di conoscenza
Un altro aspetto fondamentale del romanzo è la passione di Roithamer per la musica. La sua abilità al pianoforte non è solo un talento da esibire, ma si rivela essere un mezzo di comprensione e conoscenza, un’apertura verso l’assoluto. Bernhard utilizza la musica come metafora della ricerca del genio, un tentativo continuo di avvicinarsi a una perfezione irraggiungibile. Il concetto di “correzione” diventa centrale in questo contesto, suggerendo che il percorso del genio è caratterizzato da un incessante tentativo di miglioramento.
La descrizione della musica come strumento di accesso a una verità più profonda conferisce al romanzo una dimensione evocativa. Attraverso le note e la melodia, Bernhard ci invita a riflettere su quanto possa essere complesso l’universo creativo. Il genio, come quello di Roithamer, non è solo eccellenza o talento, ma anche uno stato di continua interrogazione e autocritica. La musica, quindi, diventa il simbolo di una ricerca spirituale che si intreccia indissolubilmente con la vita di chi crea.
“Correzione di Thomas Bernhard, quindi, non è solo la storia di un uomo, ma un’affermazione potente sulla condizione umana, l’arte e il conflitto permanente tra aspirazione e realtà.” L’opera ci costringe a confrontarci con le nostre ossessioni e con la fragilità dell’esistenza, mentre ci guida attraverso i labirinti della mente e dell’emozione.